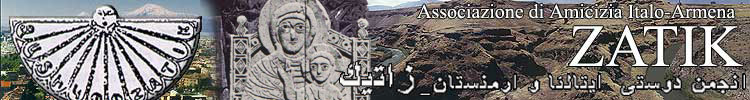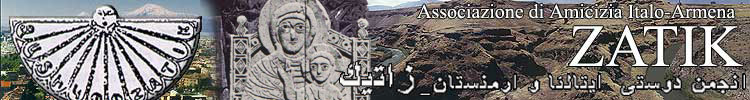Dario il Grande, una
lezione storica
Persecuzioni, emigrazione e accoglienza
Pubblicato
su "Vita e Pensiero. Bimestrale dell'Università
Cattolica di Milano".
E idem sul quotidiano Europa, Roma, 17/5/2008
Non
bisogna mai mettere un uomo nella condizione di non aver niente
da perdere.
Aforisma zingaro, secolo XIX
La dea Anahid
e l’inizio della storia
È una dea che possiede mille laghi
e mille fiumi. Sulle rive di questi laghi sono state costruite
magnifiche case, ognuna delle quali ha cento finestre luccicanti
e mille colonne magnifiche e ogni casa posa su una piattaforma
di mille pilastri (dall’Avesta, libro sacro dello zoroastrismo,
Yasht, 6).
La dea Anahita (in lingua pahlavide,
l’antica lingua persiana), Nahid (in persiano moderno
e contemporaneo) e Anahid (in armeno) era adorata particolarmente
dalle giovani donne e dalle ragazze di religione zoroastriana
(persiane, armene, assire, caldee, azere ecc.), in quanto custode
delle acque, della fertilità e della vita. Era la dea
della verità e giustizia, talvolta anche della castità,
e il suo culto si diffuse quasi come una religione su tutto
il territorio caucasico, iraniano e dell’Asia Minore,
ovvero Anatolia (in greco Anatolì, Oriente), dove disponeva
di numerosi santuari. Santuari ricchissimi – visto che
erano venerati non soltanto dai re e dalla classe dirigente
iraniana e/o armena, ma anche dai popoli limitrofi, fino al
lontano Rajastan, in India.
La pianura di Teheran era dedicata alla dea e comprendeva anche
l’antica città di Rey (Raga o Rages in latino,
Rhagae in greco), fondata nel X secolo a.C. e posta sulla Via
della Seta. Di questi santuari oggi rimangono scarse tracce.
In Iran, a Kangavar, villaggio situato nel lontano Kermanscià,
nel profondo sud del paese, sopravvive un solo tempio che come
struttura architettonica somiglia in modo straordinario ai grandi
templi greco-romani conosciuti. In Iran questi templi, assieme
a quelli zoroastriani, sono stati rasi al suolo – dapprima,
e con grande accanimento, da Alessandro Magno e successivamente
dagli arabi islamici sunniti (nell’VIII secolo) e poi
dal mongolo Tamerlano, detto Timur lo Zoppo, nel 1220.
L’Islam sciita, che perseguiterà gli zoroastriani
lungo tutta la storia iraniana, ha comunque dimostrato un certo
rispetto per i templi della dea Anahita. A Yazd – città
situata nel centro dell’Iran, che fu un importante centro
zoroastriano e oggi è abitata da qualche “sopravvissuto”
– ci sono i ruderi di piccoli templi quadrati dedicati
a Bi-bì Sciahr-banù o Shahr-zad, la “Signora
della città”, ovvero la Regina Anahita, e accanto
a vari altri ruderi anche un tempio dedicato a Vahram (il Vittorioso,
l’indistruttibile). Sul modello della dea Anahita, l’Islam
sciita a sua volta dedicò varie città alle figure
femminili sante o santificate: la città santa di Ghom
(nell’Iran centrale) alla sciita Santa Masumè;
Damasco alla Santa musulmana sunnita Zeynab; persino la Medina,
che si trova in Arabia, nel cuore dell’Islam sunnita,
a Donna Fatemè, figlia del profeta Mohammad. Anche gli
armeni, dopo averla intitolata in un primo tempo ad Aramazd
(ossia lo zoroastriano Ahura-Mazda), consacrarono alla dea la
città di Anì (“Città di una e mille
chiese”, oggi in Turchia).
La città
di Rey: una città sfortunata
La sfortuna si accanì contro la
città di Rey, sacra a Malek (“Regina del Paese
Anahita”), posta 50 chilometri a est dell’attuale
Teheran e fondata nel IX secolo a.C.: Alessandro Magno la diede
alle fiamme con tutti i codici che vi si trovavano; assassinò
tutti i Mogh (“Mago”, Magos in greco, ovverosia
componente del clero zoroastriano), distrusse i templi e l’intera
città. Secondo lo storico greco Strabone un pesante terremoto
completò l’opera. Più tardi, nel 312-280
a.C., il greco Seleucus Nikater ricostruì la città
e la ribattezzò con il nome di Europos (Europa), erigendo
nelle vicinanze altri tre centri. Uno lo chiamò Apamea
in ricordo di sua madre. Gli altri due furono distrutti dagli
arabi nell’VIII secolo e successivamente dai mongoli (XIII
secolo), e oggi di essi non rimane memoria.
Al pari delle sue “sorelle”, la città di
Rey cadrà dapprima sotto giogo arabo e poi sotto quello
del mongolo Tamerlano, che invase l’Iran nel Trecento
(1219-1223). I sopravvissuti alla distruzione della multietnica
Rey – c’erano gli sciiti con le loro filiazioni,
quasi una ventina, i musulmani sunniti con due derivazioni,
gli ebrei, gli armeni con due diramazioni (chiesa armena e chiesa
armena cattolica), i georgiani (idem come gli armeni); c’erano
i Lori, gli zoroastriani di varie risme, i bakhtiyari, ecc.
– si riversarono in due villaggi: Teheran (oggi capitale
dell’Iran, conta all’incirca 12 milioni di abitanti)
e Mehran (“Città amorosa”, oggi cancellata
dalle mappe). La città di Rey aveva quasi 450mila abitanti
(un’enormità per quei tempi). Gli ebrei, i persiani-zingari
e gli armeni presero la via verso nord – dapprima verso
il Caucaso, l’Asia Minore e i dintorni del Mar Nero e
poi verso i Balcani e l’Europa, portando con sé
una quantità di mestieri “universalmente validi”,
mestieri cioè che nel caso di emigrazione e cambio del
paese non sono soggetti a perdere la loro validità. Ad
esempio se un avvocato cambiasse proprio paese, dovrebbe iniziare
tutto daccapo e per prima cosa apprendere una nuova lingua;
non così un dentista. I persiani transumanti, che comunque
erano sedentari, divennero zingari, ovvero “girovaghi”
e diffusero in tutto il mondo la musica; gli ebrei fecero lo
stesso con la finanza – crearono due nuovi stati ebraici
nel Nord: Khazero sulla litorale del Mar Caspio ed Eshkenazita
(da non confondere con gli Eskenaziti europei) sulle rive del
Mar Nero e del Mar d’Azov. Gli armeni si concentrarono
sulla medicina e sull’architettura, e così via.
Nei secoli successivi e nel XIX-XX secolo tutte e tre queste
etnie, com’è noto, vennero pesantemente perseguitate.
Gli zingari e
la musica, mestiere per emigranti
Fin dai tempi più remoti gli zingari,
di razza indo-europea, si occupavano della musica e del ballo.
Secondo una mitologia diffusa fra tutti i popoli mediorientali
e particolarmente nell’ambito dello zoroastrismo, il mondo
iniziò per volontà divina con un big-bang musicale.
E la Terra, a sua volta, ha bisogno di ricordare costantemente
l’attimo della propria creazione. Ogni giorno occorre
battere coi tacchi per terra e suonare e cantare qualcosa. Così
nacquero il canto e la danza e la musica, sia in ambito religioso
che in ambito popolare. Lo zoroastrismo glorificava il creatore
facendo ballare in tondo attorno al fuoco sacro i mogh (“maghi”,
preti zoroastriani), che procedevano lungo la figura di una
swastica (segno di croce ruotante). Un simbolo che si diffuse
sia tra i cristiani d’Oriente che tra i monaci bizantini,
fino ai sufi dell’Islam sciita e sunnita. Oggi come oggi,
ma ormai in modo del tutto alienato – spesso per mero
diletto dei turisti – i sufi musulmani sunniti di Turchia
ballano e danzano ancora in identico modo.
La swastica con le braccia uncinate verso sinistra, in senso
antiorario, è simbolo del sole e della vita; se invece
le braccia sono orientate in senso orario di rotazione (su-wastika)
è simbolo della morte e della distruzione.
La formazione
di un popolo: una storia di cavalli e di musica
Gli zingari persiani-zoroastriani aderirono
alla figura della dea Anahita, che si presentava, sempre nell’ambito
dello zoroastrismo, sintetizzandosi a mo’ di nuova religione.
Portarono in giro come Parola di Dio i canti e la musica in
tutto il Medio Oriente – sempre ballando su un tracciato
a forma di svastica, cioè di croce ruotante –,
giungendo fino in Spagna e anche oltre. Si spostarono senza
fatica poiché, pur essendo in origine sedentari, seppero
tramutarsi in transumanti, occupandosi prevalentemente dell’allevamento
di mandrie di cavalli per l’esercito persiano e altri
eserciti dell’area.
I cavalli a cui si dedicavano erano in maggior parte cavalli
armeni, originari del Gharabagh (ghara, in turco, “nero”;
bagh, in persiano, “giardino”, oggi in russo Nagorno-Karabak),
dal mantello giallo oro, nero, fulvo o bianco, provvisti della
particolarità che l’altitudine di quelle montagne
non procurava loro nessuna vertigine, evitando così cadute
rovinose per il cavallo e il cavaliere. In effetti lo zoroastrismo
curò in modo spasmodico l’allevamento e l’addestramento
dei cavalli, vietando tassativamente qualunque utilizzo a scopo
alimentare degli animali da soma (asini, cammelli, muli, cavalli
e addirittura vacche e buoi) e promuovendone altresì
la tradizione – che resiste ancor oggi in molti Paesi
mediorientali, persino nel seno di altre religioni come il cristianesimo
orientale, l’induismo, l’Islam ecc. Gli Sciti (popolazioni
storiche della Siberia del sud e del Caspio settentrionale)
per le loro scorribande nelle steppe poterono disporre di cavalli
persiani specializzati nel fiutare la neve scovando l’erba
fresca nascosta sotto la crosta di ghiaccio.
Storia di una
persecuzione millenaria
Nel XIII secolo gli zingari persiani
rifiutarono di vendere i propri cavalli a Tamerlano e ad altri
Khan mongoli, rimanendo fedeli all’impero persiano e ai
popoli dell’area. I cavalli mongoli si rivelarono del
tutto inadatti ad attraversare il Caucaso, che costituisce un
muro fortificato naturale di difesa, com’era già
successo con gli arabi, che si erano vendicati radendo al suolo
tutta la piana armena. In tal modo fu impedita loro la penetrazione
verso i Balcani e l’Europa. Lo stesso vollero fare i Mongoli,
ma i monti caucasici per i loro cavalli erano insuperabili e
per penetrare in Russia e in Europa furono costretti a trovare
una via settentrionale costeggiando il Mar Caspio, perseguitando
gli zingari ogni volta che se ne presentò l’occasione
in quanto distruttori del progetto – nato sulle orme di
Alessandro Magno – di creare un impero mongolo d’Oriente
e Occidente (ovvero Eurasia: un impero che si sviluppava tra
due oceani – dall’Atlantico al Pacifico –
e che avrebbe dovuto comprendere tre continenti, l’Europa,
l’Asia centrale e periferica e la Cina). Più avanti
gli zingari transumanti della città di Rey e dintorni
si convertirono quasi tutti al cristianesimo e si fecero ribattezzare
rom: termine arabo che significa “greci e/o romani”,
ovvero “gente d’Occidente”.
Le fila di costoro vennero irrobustite con l’aggiunta
dei koulì persiani – cioè “gente con
averi sulle spalle”, che storicamente erano dei vagabondi
che rigettavano la proprietà privata e vivevano in tende
allestite fuori delle mura delle città. I koulì
giravano per il paese e diffondevano la danza, esordendo con
le braccia alzate, in segno di glorificazione di Ahura-Mazda;
rigettavano le altre religioni rivelate, poiché contrarie
alla danza e alla musica, come l’ebraismo e il cristianesimo
orientale e l’Islam sciita. Provvedevano ad accompagnare
con canti e musiche le feste e i matrimoni, portandosi dietro
i loro strumenti musicali un po’ dovunque, organizzando
spettacoli teatrali – per certi versi paragonabili a quelli
circensi –, allettando gli spettatori con la lettura della
mano e del futuro. Erano specializzati nella fabbricazione di
strumenti musicali a fiato e nella lavorazione del rame per
usi domestici, per confezionare talismani di buon augurio matrimoniale,
salute o lunga vita. Si spinsero verso il Mar Caspio e il Mar
Nero. A costoro si unirono i cantautori del Caucaso coi loro
tar (strumento simile alla chitarra), i cantautori-poeti detti
Asciugh (“innamorati” o “pazzi di Dio”
in arabo, ashik in turco, asciugh in armeno), poliglotti, colti
e provenienti da tre villaggi situati nel cuore dell’Armenia
orientale. Vagabondi – simili ai dervisci ma esclusivamente
laici – diffondevano in ogni dove, insieme agli zingari
e ai koulì, la filosofia, la storia, la poesia e l’amore,
dapprima verso il Caucaso, poi verso l’Asia Minore, seguendo
le rotte balcaniche fino all’Europa settentrionale, percorrendo
anche la rotta verso ovest, in direzione della Francia del Sud
fino alla Spagna e al Portogallo, contribuendo alla formazione
di vari flamenchi, sempre portando con sé le strutture
occorrenti per i loro spettacoli e ogni tipo di strumento musicale.
A partire dal 1880 arrivarono addirittura negli Stati Uniti.
Gli europei a loro volta perfezionarono tutta questa eredità
ricevuta dall’Oriente, e dal Rinascimento svilupparono
ed elaborarono proprie musiche, canti e balli attraverso la
diffusione seguita a quella lontana emigrazione dalla città
di Rey e dintorni. Se non ci fossero stati questi zingari indo-europei,
oggi ad esempio forse non ci sarebbe stato un Bach, un Liszt,
uno Hummel, un Brahms, un Ciajkowskij, un Rakhmaninov, un Bela
Bartok, un Frédéric Chopin, un Wagner. E per quanto
riguarda i secoli successivi Adolf Hitler – per non essersi
trovato i Mongoli come vicini di casa e come compenso per ringraziarli
– nel 1944 organizzò una “Notte Tzigana”,
massacrandoli a più non posso e bruciandoli nei forni
crematori di Dachau, Mauthausen, Auschwitz, Birkenau (quest’ultimo
era un campo speciale riservato agli zingari). Il numero esatto
non si sa, ma qualcuno mormora: da due a quattro milioni. Lenin
e Stalin da parte loro ne mandarono parecchi a spaccare le pietre
nei gulag sovietici (il numero preciso non si conosce, qualcuno
parla di circa di un milione e mezzo di persone). Ugualmente
si ignora a tutt’oggi il numero esatto dei giovani e dei
pupi che finirono nelle mani del Dr Joseph Mengele come materia
prima per i suoi “esperimenti”.
«Quando il bastone divino colpisce,
generalmente non fa rumore»
Aforisma armeno, XIX secolo
Anche la “civilissima Svizzera”
cercò di sedentarizzare gli zingari, togliendo loro i
figli per annientare in modo soft la discendenza e la prosecuzione
della razza e sterilizzando anche le donne. Ma il buon Dio –
ovvero Ahura-Mazda – non donò agli svizzeri né
un compositore, né una poesia, né una musica,
né un canto o una danza degni di nota.
Il modello svizzero ebbe un certo successo:
le sterilizzazioni di massa degli zingari Rom, Sinti e Kali
ebbero luogo anche in Ungheria, in Cecoslovacchia, in Bulgaria
e in Spagna.
Un altro colpo di grazia fu predisposto dalla Nato e dai suoi
comprimari europei nella ex Yugoslavia e nei Balcani. Oggi i
discendenti di questo popolo sono ridotti alla miseria e si
trovano sparsi in vari paesi europei: suonano nei metrò,
praticano l’accattonaggio e talvolta rubacchiano a destra
e a sinistra per racimolare qualche soldo (a parte qualcuno,
come Goran Bregovic, che può dire di avercela fatta).
Nel 1970 avevo preso parte a un matrimonio zingaro in Romania,
e volevamo, con l’amico musicista Ludwig Bazil , organizzare
un concerto a Milano per mettere l’accento sulle origini
della musica occidentale. Alla fine non ci riuscimmo perché
a Milano vi fu un “grande rogo”, battezzato in seguito
“Mani pulite”, e l’assessore comunale alla
cultura Guido Aghina, che avrebbe potuto aiutarci a realizzare
il nostro bel progetto, dovette abbandonare il suo posto.
«Quando una foresta brucia,
cespugli maleodoranti e innocenti grandi alberi di noce bruciano
insieme»
Aforisma degli zingari armeni, XIX secolo
D’altronde questa eredità
musicale è così immensa che il governo islamico
dell’Iran ha creato un istituto di ricerca che già
ha pubblicato i primi tre volumi di una Encyclopaedia of the
Musical Instruments of Iran a cura di Mohammad-Reza Darvishi,
prevista in dieci volumi; ogni volume è di grande formato
e di quasi 600 pagine.
Persecuzioni,
emigrazione e accoglienza
L’imperatore persiano Dario il Grande: una lezione storica
Nell’autunno del 2003 Bahram Ghassemi,
ex ambasciatore persiano a Roma, organizzò una cerimonia
in occasione del conferimento di un’onorificenza per meriti
culturali al sottoscritto. Nel salone di ricevimento delle autorità
dell’ambasciata trionfava appeso al muro, per onorare
un concittadino cristiano, un grande tappeto persiano antico,
pulito e restaurato per l’occasione, che raffigurava L’Ultima
Cena. E mi disse: «Proprio non capisco il perché
del mugugno italiano circa le problematiche dell’emigrazione
straniera in Italia, che è di consistenza tanto scarsa.
Dall’Afghanistan, nel corso della guerra con l’Unione
sovietica, a noi arrivarono in un colpo solo circa due-tre milioni
di persone. Non sappiamo e non sapremo mai il numero esatto.
Comunque era gente che aveva fatto la guerra per lunghissimi
anni, gente affamata, gente piena di rabbia, che ci ha fatto
vedere i sorci neri. Eppure in qualche modo siamo riusciti a
dare a tutti un tetto, o almeno un bugigattolo, e a organizzare
scuole per i pupi e per la gioventù sotto le tende, perché
non disponevamo di un numero sufficiente di edifici vuoti. È
noto quanto siano fondamentali asili e scuole per “contenere”
un’immigrazione selvaggia, partendo da pupi e dai giovanissimi.
Comunque i soldi spesi per l’accoglienza sono sempre un
terzo di quelli spesi per la sicurezza e da sempre hanno dato
risultati migliori. Quello che a noi dispiace, è che
non abbiamo potuto mettere le mani sulla “crema afghana”,
cioè sull’aristocrazia, sull’intellighentsja,
sui laureati in genere, sui medici ecc. In compenso, qualche
tempo dopo ci sono riusciti gli americani».
L’imperativo dell’accoglienza
fu la grande lezione politica dello zoroastriano achemenide
Dario il Grande, E successivamente divenne un imperativo politico
in tutte le aree del Medio Oriente e fu seguito da quasi tutti
i sovrani persiani – così come da quelli degli
altri paesi limitrofi mediorientali – nell’arco
della loro lunga storia. Dario stesso fece emigrare dalla Palestina
quasi cinquantamila ebrei per impostare l’amministrazione
dell’Impero persiano. E una volta terminato il lavoro,
il suo successore Ciro il Grande ricostruì anche il tempio
ebraico di Gerusalemme e lasciò che gli ebrei tornassero
a casa, donando a ciascuno un sacchetto d’oro. Ciro dagli
ebrei ottenne il titolo divino di “Unto del Signore”
Qualche milione di armeni sopravvissuti
al genocidio del 1914-18 giunse in Iran, Iraq, Siria, Libano,
Cipro, e perfino in Etiopia, Egitto e Libia. In questi paesi
trovò sempre porte aperte all’accoglienza, insieme
a documenti personali, orfanotrofi, “case per donne sole
con bambini sopravissuti”, lavoro e il permesso di costruire
proprie scuole e chiese.
Su questo modello si muoverà anche
l’Algeria dopo l’indipendenza, visto che c’era
tanta gente d’origine medio-orientale, laureata e disponibile,
sparsa a macchia di leopardo in tutti i paesi europei, arrivata
per completare gli studi superiori e poi impossibilitata a tornare
a casa. Costoro avevano problemi con i propri sistemi governativi
(ovvero con le dittature mediorientali). Generalmente la loro
colpa fu che erano portatori di pezzettini di democrazia di
tutte le risme possibili e immaginabili: laici o religiosi che
fossero.
L’Algeria indipendente trovò per loro un lavoro
(spesso e volentieri nel campo dell’edilizia e dell’architettura)
e una casa; in particolare seppe garantire la sicurezza fisica
a tutti costoro e alle loro famiglie. Ma il “foraggiamento”
dei “Fratelli musulmani” da parte della Francia
portò infine a una guerra civile (circa 220mila morti
– il numero esatto, ancora una volta, non lo sapremo mai)
e sprofondò di nuovo il paese nel Medioevo. Il quale
paese iniziò comunque a “sputare” petrolio
e gas a favore dell’Occidente in generale e della Francia
in particolare. Questi emigrati – spesso e volentieri
anche persiani – finirono col ri-emigrare e vennero “risucchiati”
dall’Europa e dagli USA.
Nel 2006, su una banchina del metrò
3 di Milano, incrociai un ragazzino Rom che suonava il violino
come un mezzo genio, sotto lo sguardo di due “marcantoni”
macedoni che intascavano i soldi, spesso e volentieri banconote,
che i milanesi di passaggio estasiati da tanta maestria elargivano
al ragazzino. Pensai che il ragazzino era destinato a un futuro
infausto. Nessuno sarebbe occupato di lui se non per usarlo
come un mezzo per estorcere denaro. Mi nacque allora una domanda.
Qualcuno avrebbe mai sentito il nome di Giuseppe Verdi, se non
ci fosse stato Antonio Barezzi di Busseto, che appoggiò
e protesse il musicista, e più avanti addirittura lo
fece sposare con la propria figlia? E Verdi, quanto lavoro e
“fatturato” ha prodotto per l’Italia? Qualcuno
dovrebbe prendere carta e matita e fare il calcolo. E Uto Ughi?
Non accogliendo quel ragazzino l’Italia ha forse rinunciato
a un fatturato futuribile, a un Uto Ughi II (lavoro, tasse e
immagine). E oggi come oggi, escludendo il ragazzino anche dalla
società e dalla scuola per avviarlo sulla strada, si
è forse tentato di creare un futuro criminale e/o, nel
caso peggiore, un terrorista?
San Pietroburgo, alias Petrograd, alias
Leningrado, è stata costruita grazie al lavoro degli
italiani ed è quasi una città italiana trapiantata
in Russia. Se non ci fosse stata l’emigrazione italiana,
i russi non avrebbero mai potuto disporre di tale meraviglia,
e nello stesso tempo gli italiani sono rimasti privi di quella
magnifica città. L’incoraggiamento nei confronti
dell’emigrazione italiana, che fu messo in atto nel secolo
scorso, specialmente da parte dei Savoia, i quali scacciarono
quasi gli italiani “poveri in canna e turbolenti”
fu un grande tradimento verso l’Italia. Oggi come oggi,
una massa di 55 milioni circa di italiani si trova all’estero.
Se fossero ancora in Italia, sommandoli alla popolazione già
residente nel paese, avrebbero reso l’Italia il paese
numero uno in Europa, escludendo qualsiasi crisi economica.
Tutte le mattine – si fa per dire – sarebbe stato
necessario preparare circa 55 milioni di caffè in più
e incassare il relativo fatturato, IVA e tasse. Tant’è
vero che, passata la “bufera”, il governo romeno
rivuole indietro i suoi 3-4 milioni di emigrati. E questo creerà
svariati problemi anche in Italia, provocando una carenza di
mano d’opera nei settori della bassa manovalanza, nella
tecnologia e nei servizi.
«Gli zingari
italiani?» «Nema problema»
Gli zingari di vario ceppo – Rom,
Sinti, Kali – di nuova e vecchia emigrazione in Italia
si calcola siano circa 150.000. È una minoranza diffusa
a macchia di pelle di leopardo sul territorio. Ma allora rappresenta
un problema marginale. Si è voluto che ci fosse il problema,
da gestire in modo opportuno e forse funzionale a certa politica
di bassa lega, ammassando e facendo vivere questa povera gente
in campi che sono un’imitazione degli stalag di sinistra
memoria, lasciando da parte l’esperienza eccelsa in questo
campo accumulata ad esempio da Don Virginio Colmegna e dall’Opera
Nomadi – a Milano la sede di questi ultimi fu oggetto
di vandalismo nell’ormai lontano dicembre del 2003. Per
sedentarizzarli basterebbe restituire loro le case, i terreni
e i permessi di accampamento, che ammontano alla cifra quasi
incredibile di 10.000 unità, insieme con il tesoro degli
zingari italiani, estorti e confiscati nel periodo fascista
e avvolti nel più completo silenzio dopo la Seconda guerra
mondiale.
Per tornare all’Iran – a causa delle persecuzioni
bolsceviche e staliniane, dalla Russia prima e dall’URSS
poi – a un certo punto laggiù sono arrivati migliaia
e migliaia di europei e asiatici d’ogni etnia, che nella
quasi totalità erano privi di documenti, perché
sequestrati a suo tempo dalla GPU prima e dalla CEKA poi (quello
che più avanti nella storia sarà il KGB). Fu un
esodo di massa, una massa candidata ad essere annientata definitivamente.
Ma il governo persiano rilasciò immediatamente permessi
di soggiorno e carte d’identità sulla sola parola
dell’emigrante. Fu il primo atto d’accoglienza,
funzionale all’inserimento di quel “soggetto estraneo”
nel seno della società. E più avanti vennero messi
in piedi asili nido e scuole elementari e medie per ciascuna
etnia: russa, ucraina, bielorussa, georgiana, armena, ebraica
orientale e tatara (turchi dell’Azerbaigian).
HERMAN VAHRAMIAN
Uno zingaro rubò due chiodi
dalle mani insanguinate di Gesù. Gli uomini lo condannarono
a un eterno vagabondaggio. Gesù sospirò di sollievo:
aveva due chiodi in meno a tormentarlo.
Aforisma risalente al 18 gennaio 1996, dopo che fui insolentito
da un milanese poiché avevo donato qualche soldo a una
zingara con in braccio un figlio piccolo.
Herman Vahramian (dottore, architetto,
giornalista)
Viale Umbria, 35
20135 Milano